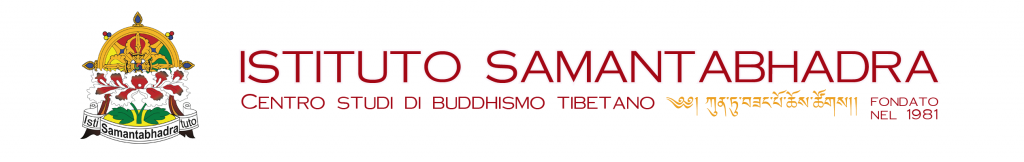La cultura che forma i ragazzi
di Antonio Polito
C’è un nesso molto stretto tra istruzione e suffragio universale, ma fa differenza il modo in cui apprendiamo: se attraverso la lettura e la comprensione di testi, più o meno complessi; oppure attraverso immagini, grafici, video, slogan
Costernati e allarmati, abbiamo fatto finta di scoprire grazie alla denuncia di Save The Children che metà dei quindicenni italiani non comprendono i testi che leggono (in realtà bastavano e avanzavano i tanto osteggiati test Invalsi). La nostra preoccupazione immediata ha riguardato, come è logico, il futuro di questi teenager: che ne sarà di loro all’università, nella vita, nella competizione sempre più spietata per i pochi lavori di qualità che il mercato offre ai giovani?
Non ci siamo chiesti però che ne sarà della nostra democrazia, quando coorti generazionali per metà illetterate diventeranno il corpo elettorale di domani. E invece dovremmo, perché c’è un nesso molto stretto tra istruzione e suffragio universale. Ralf Dahrendorf, il grande sociologo anglo-tedesco, era solito sostenere che la democrazia non può esistere senza cittadini. Senza un dibattito informato. Senza una «sfera pubblica», e cioè senza uno spazio di incontro tra soggetti liberi e con uguale diritto di parola, che sottopongono al vaglio reciproco le loro idee-opinioni, espresse attraverso forme argomentative (così Massimo Cerulo definisce la «sfera pubblica», traducendo il termine tedesco usato da Habermas).
Serve dunque un luogo, anche virtuale, diciamo pure un’agorà, in cui esistano le condizioni per cui io possa avere speranza di convincere qualcun altro con la forza delle mie argomentazioni, e viceversa. Se così non fosse la democrazia, che come è noto non si esaurisce nel momento elettorale, diventerebbe una cosa vuota, facile preda di demagoghi, fanatici, e aspiranti tiranni (tanto per dare un’idea: anche in Russia e in Iran il popolo vota ed elegge il suo presidente, ma è difficile definire democrazie quei sistemi).
Il bisogno di avere cittadini attivi e informati, materia prima della democrazia, angustia del resto gli inventori di questo sistema politico fin dagli albori. Dopo il periodo del Terrore, nella Costituzione dell’Anno III (1795), i rivoluzionari francesi che avevano preso il posto dei giacobini scrissero che entro un decennio i giovani avrebbero dovuto provare di saper leggere e scrivere per ottenere l’iscrizione al registro elettorale. Ma giustificavano questo criterio censitario-culturale, che contraddiceva il principio del suffragio universale, riponendo un’illimitata fiducia nella forza egualitaria dell’istruzione: erano cioè convinti che la diffusione di cultura e conoscenza avrebbero fatto il miracolo di formare dei veri cittadini, liberi di pensare con la propria testa, e per questo vararono una serie di misure radicali per l’educazione, dalla scuola primaria gratuita per tutti, alla fondazione dell’École Normale, all’introduzione del sistema metrico decimale.
Le moderne liberal-democrazie hanno progressivamente risolto il problema con la scolarizzazione e l’alfabetizzazione di massa, e con la riduzione delle disuguaglianze sociali nei trenta formidabili anni di crescita successivi alla guerra. Ma il problema si ripresenta oggi in forme del tutto nuove.
L’antico divario tra colti e ignoranti, tra scolarizzati e analfabeti, ha infatti lasciato il posto a una nuova divisione, nella quale non ci sono più ignoranti nel senso letterale del termine. Oggi tutti, o quasi tutti (con l’eccezione degli anziani che non hanno accesso agli strumenti digitali) sanno. Nessuno ignora, né accetterebbe mai di ignorare. La partecipazione al dibattito nazionale, a quella «sfera pubblica» di Habermas di cui parlavamo, appare assicurata a tutti dalla Rete e dai social. Per questo a molti è parso che le nuove tecnologie potessero dar vita a una democrazia più genuina.
Pages: 1 2